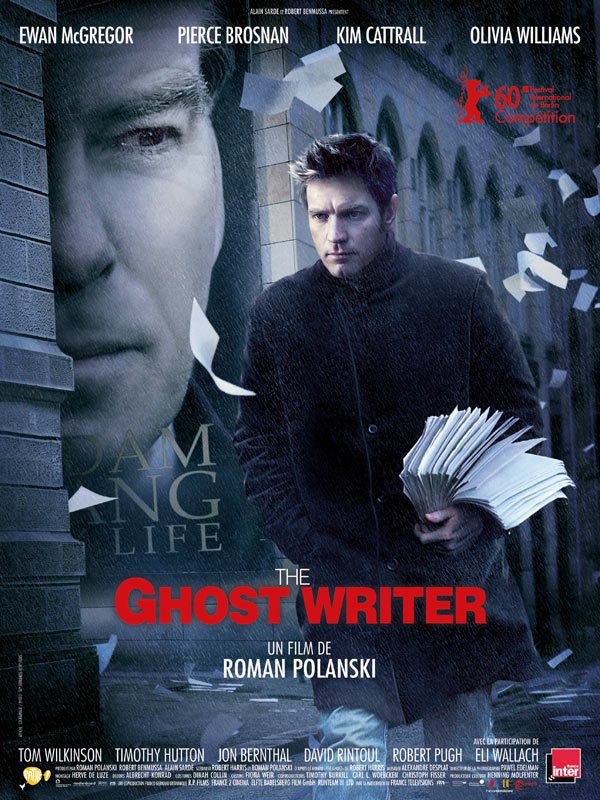E’ italiana ma vive a Londra dove – in barba alla Brexit in itinere – lavora tranquilla da anni. Alice Bottarini è una colour designer – anzi: colour design manager – e lavora nel settore dell’automotive di lusso. In cosa consista il suo lavoro, non l’ho mai veramente capito… almeno fino a un anno fa, quando Alice mi ha dato appuntamento a Parigi, nel Marais, “Accompagnami in giro per negozi, sono qui per la mia azienda. Così mi vedi in azione e capisci che lavoro faccio”. Un invito a nozze: da brava curiosa cronica, non me lo sono fatta dire due volte e così mi sono trovata in giro con lei tra gallerie d’arte e negozi di design. L’intervista vera e propria è iniziata in un negozio di arredamento, mentre la guardavo alzare le antenne, toccare tutto e registrare ogni cosa nei minimi particolari.
Dunque, partiamo dall’ABC. Perché siamo qui?
Quando entri in un negozio come questo, che è pieno zeppo di oggetti di design, riesci a capire subito qual è la tendenza attuale e quali saranno le tendenze future.
Ah sì?
Bè, certo… ovviamente devi essere un addetta ai lavori e bazzicare il nostro ambito. Per esempio, guarda qui: abbiamo delle sedie verde scuro, bordeaux e color panna rosato, su uno sfondo color aragosta. Non sono colori convenzionali, giusto? Ecco, mi basta questo per iniziare a fiutare il cambiamento e capire in che direzione si sposteranno i colori perché l’anno scorso, quando sono venuta qui, le tonalità dominanti erano di tutt’altro tipo: c’erano il blu, il bluette…
Ma di preciso – al di là del fatto che ora li trovi in questo allestimento – cosa capisci a partire dalle tonalità di questi oggetti?
Capisco che in futuro – e ti parlo di futuro prossimo – sul mercato sbarcheranno queste tonalità, che insieme allo sfondo aragosta ti fanno capire che ci sarà un ritorno ai colori tendenzialmente più saturi. Tu conta che il colore sugli oggetti o sull’automobile manca da una decina di anni: un sacco di tempo. Quindi che succede? Gli acquirenti iniziano a stufarsi ed ecco che il mercato comincia a riproporre le tonalità pop che andavano in voga negli anni Cinquanta.
Un revival, quindi?
No, non proprio: diciamo che si tende a prendere ispirazione da quell’universo cromatico rivisitandolo. Prendiamo un colore a caso, il viola: lo ritroverai ma traslato in un viola bordeaux elegante. Niente a che vedere, quindi, con l’effetto piatto delle vecchie tonalità pop! Quello che tenderà a emergere verrà percepito come qualcosa di diverso, di più elitario.
Ma come nascono le nuove tendenze del colore?
Il punto di partenza è…
L’automobile.
No, quello è il punto di arrivo. Il punto di partenza è sempre l’oggetto meno costoso. Prendi ad esempio il tuo portafoglio (ndr: portafoglio in plastica iridescente, mostruosamente kitsch. L’ho scelto apposta per questo).
Bè, cos’ha il mio portafoglio che non va?
Nulla. Tu lo hai portato a casa pensando che la tua fosse una libera scelta, una forma di autoironia ecc.
Un gesto dadaista…
Ecco. E invece no. Fra tutti i portafogli che avevi davanti, hai scelto l’unico che si distingueva da tutti gli altri, quello che avevi visto di meno… lo so che non la prenderai bene, ma in pratica sei entrata dritta dritta in un meccanismo perfettamente congegnato, che funziona proprio così: si inizia con l’introdurre le nuove tendenze cromatiche partendo dall’oggetto più economico per entrare nella sfera dei consumi di massa. Parti dallo smalto, dal portafoglio, dall’oggettino economico di Accessorize e poi magari tra tre anni Burberry ti propone il solito trench marrone con i colori del tuo portafoglio.
Mi stai dicendo che uscirà un trench iridescente?
Bè, guarda caso ne è già uscito uno con il bordo fluorescente. E’ così che prende forma il processo di innovazione del prodotto: in modo ragionato e tutt’altro che eclatante.
Ma come funziona esattamente il processo: si inizia col proporre ai clienti una gamma di colori, studiandoli e selezionando poi, in seconda battuta, quelli che gli acquirenti scelgono? O il colore dell’anno viene deciso a tavolino e poi “calato dall’alto”?
Esistono degli studi specifici, predefiniti, in base ai quali si sa già che il tal colore avrà una determinata possibilità di durata sul mercato, in relazione a un target specifico di acquirenti. Per quanto riguarda l’automobile, che come bene di consumo dura molto di più rispetto a un portafoglio, si tende a puntare su colori come il blu, il nero o l’argento. Tonalità che dureranno di più perché non annoiano. Quando invece l’obiettivo è quello di “stancare” più velocemente l’acquirente – inducendolo quindi ad acquistare più spesso – ecco che viene scelta una gamma di colori diversi. In questo caso, quindi, vengono introdotte delle tonalità che il tuo cervello elaborerà più velocemente.
Obsolescenza programmata applicata al colore, in pratica. Fammi un esempio.
Tipo, in un cappotto vengono inseriti dei particolare per cui dopo un anno ti stufi e cambi. In questo modo ti abitui a preferire sempre ciò che percepisci come una novità rispetto a ciò che il tuo cervello ha registrato come assodato.
Quindi, ricapitolando, il tuo lavoro consiste nel bazzicare negozi di design e simili per cercare di indovinare quali tendenze cromatiche si affermeranno nel mondo dell’automobile?
No, non tiro a indovinare: so che dall’esterno può sembrare strano (e anche un po’ magico) ma di fatto in base all’assenza o alla presenza in un determinato luogo, riesci a percepire con esattezza quando un colore tornerà sul mercato, quanto resterà e quando tramonterà. Nel 2006, per esempio, il marrone era il grande assente del momento e io mi sono ritrovata in università con una professoressa che mi diceva: vi ritroverete ad amare il marrone. Oggi, di recente, il marrone “è tornato” … ma i professionisti ci stavano già lavorando su da allora.
Quanto tempo passa dal momento in cui si inizia a cercare di introdurre un colore al momento in cui quel colore si afferma?
Dipende da che colore è e dipende da dove lo vuoi fare arrivare. Per esempio, come ti dicevo il mercato dell’automotive è il punto di arrivo finale. Quando si crea un prodotto, ci si regola di conseguenza. I designer quindi, se vogliono un oggetto poco durevole, vanno a vedere gli occhiali (che escono ogni sei mesi) e cercano di capire quali saranno le tonalità di grido in questo modo; se invece hai un progetto più a lungo termine, vai a vedere i mobili.
Ma chi è che “crea” le nuove tendenze?
I grandi brand, ovviamente. Quali, non posso dirtelo ma considera che in certi casi alcuni brand sono riusciti non solo a creare una tendenza nell’ambito del colore o del design ma anche a fagocitare l’oggetto stesso. Quando inizi a chiamare un prodotto con il nome del marchio, ecco che il marchio diventa iconico: prendi lo scotch, per esempio.
Abbiamo parlato di brand e di mercati, ma dimmi… il colore è così “meditato” anche in ambiti diversi, esterni rispetto al mercato?
Certo. Ti faccio un esempio che riguarda un contesto totalmente diverso, il mondo dell’urbanistica. Nelle strade in cui si vuole scoraggiare l’uso dell’eroina, vengono utilizzate luci dello stesso colore delle vene. Cioè tendenti al blu.
Perché?
E’ tutto un gioco di colori complementari. Per esempio, il complementare del blu è il giallo. Se tu metti una palla blu su uno sfondo giallo, trovi subito la palla.
Cioè, è più facile riconoscere un oggetto quando è vicino a un altro oggetto di colore complementare. Giusto?
Esatto. Torniamo alla nostra palla: se tu metti una palla blu su un prato blu, ecco che non trovi più la palla. Per lo stesso motivo, in certe vie, vengono utilizzate luci con tonalità tendenti al blu: in questo modo farai più fatica a distinguere le tue vene.
Mi togli un’ultima curiosità? Ti ho vista, prima, mentre annusavi un sottopentola. E ora ti vedo che tocchi tutto minuziosamente…
Certo, lo faccio apposta. Anche il tattile ti dice qualcosa dell’idea che il colore dovrà produrre. Idem per la sensazione olfattiva. Ho annusato quel sottopentola per capire se sapeva di ferro o di plastica. Il colore non è una stanza chiusa, ma un campo aperto anche a tutte le altre percezioni sensoriali. Quando crei un colore, di fatto, devi essere in grado di riprodurre – insieme a quel colore – anche una determinata sensazione tattile o olfattiva. In modo sinestetico, quindi.